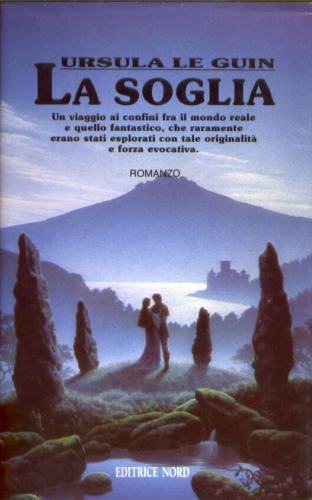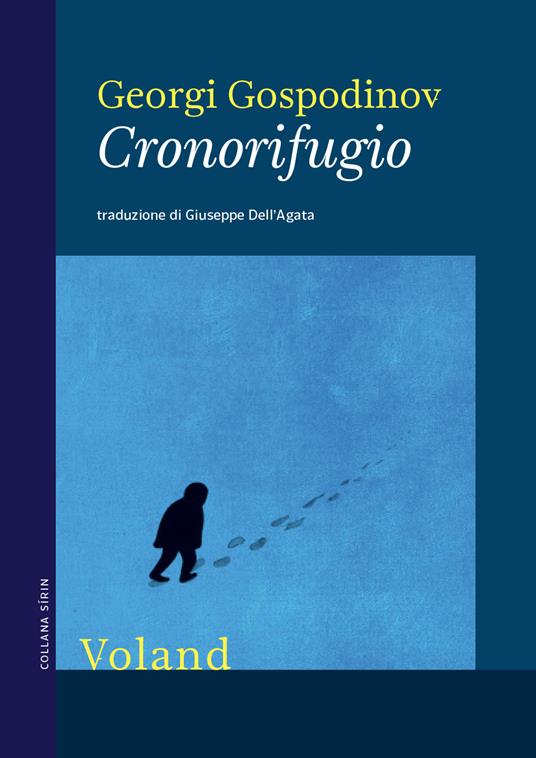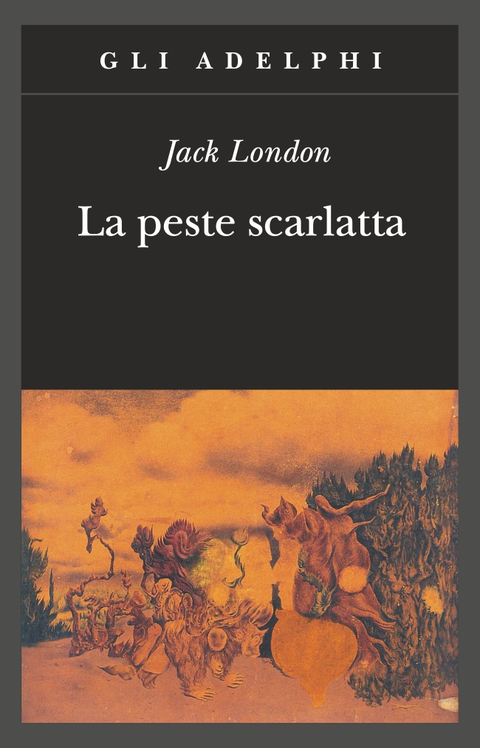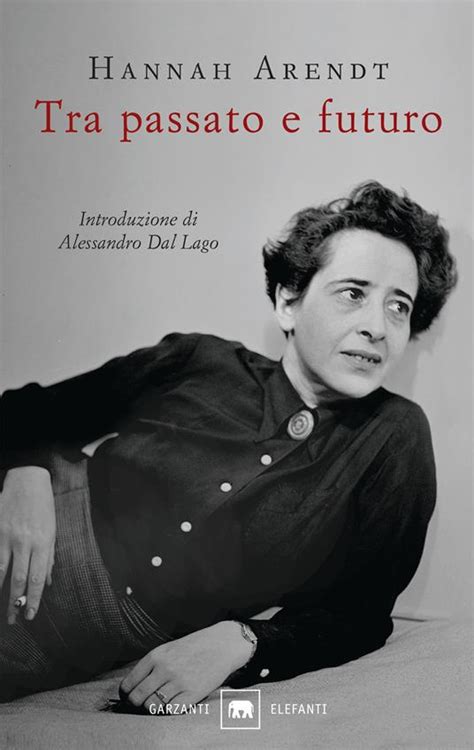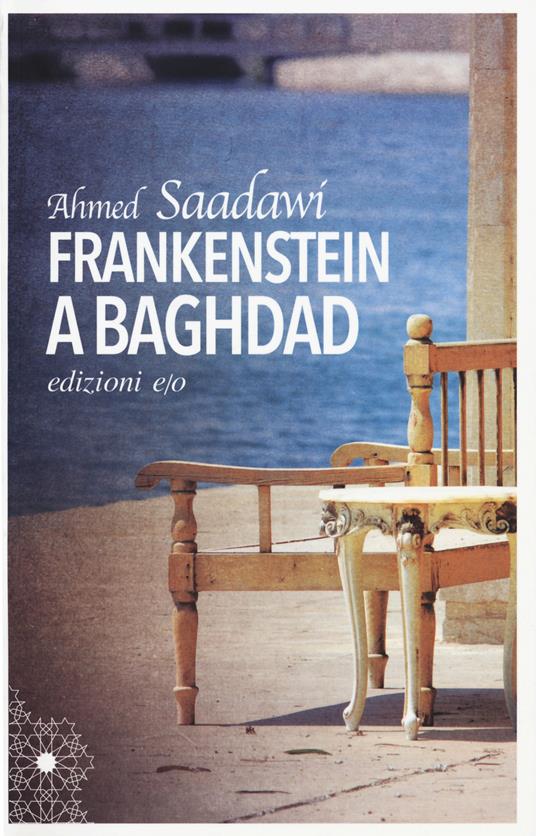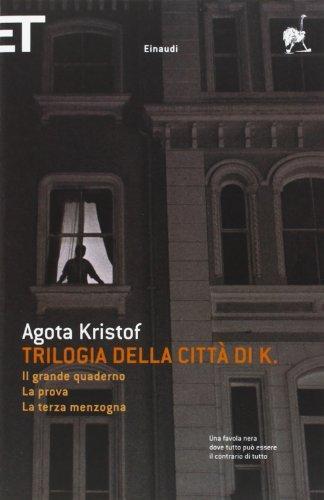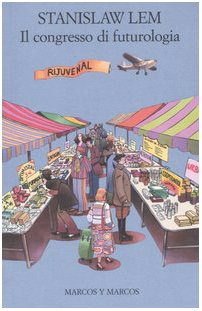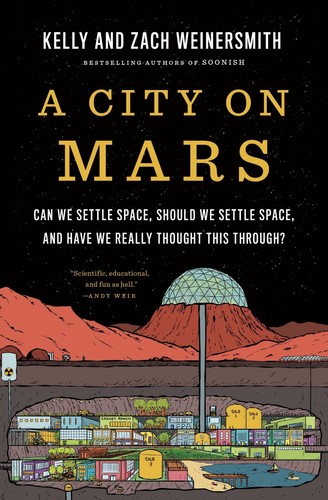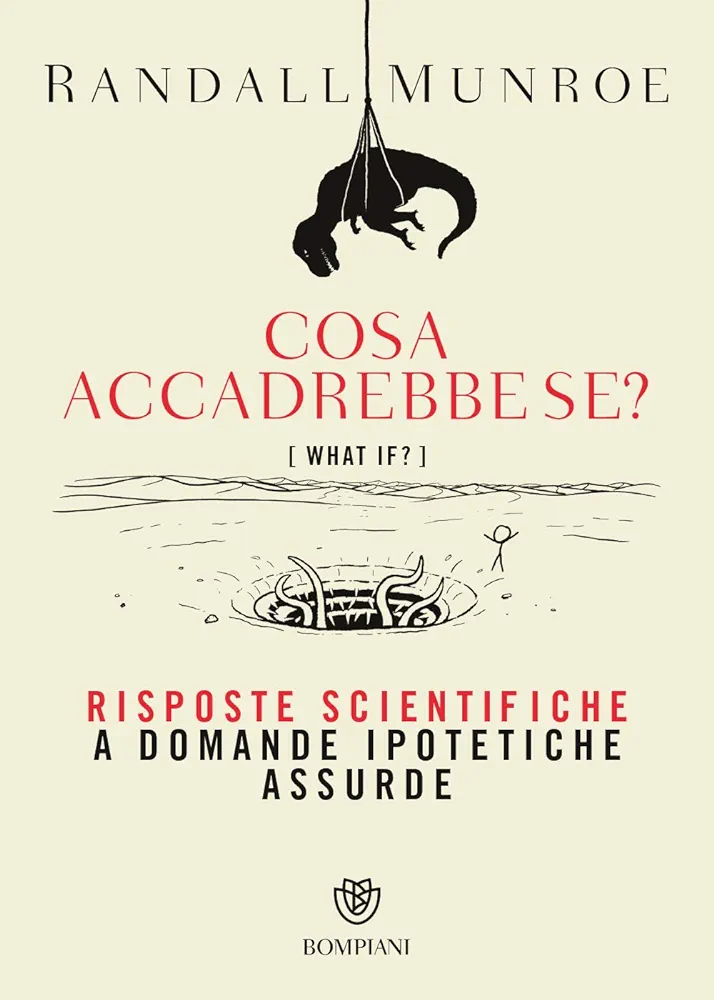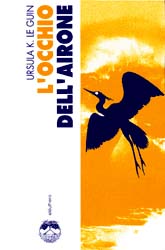dal racconto "Storia di un boxeur"
Viveva i suoi sedici anni circondato dal rispetto generale: aveva smesso di boxare, ma la faccia sfigurata, e il ricordo delle tante vittorie, formavano come uno scudo fra lui e gli altri; lo si trattava coi guanti; ogni sua richiesta di favore era quasi un ordine, per chiunque... non si sa mai che decida di mollarmi una manata.
È stata grande quindi, anni dopo, la sorpresa dei rispettosi concittadini quando il diciannovenne Marcello è apparso sulle pagine di cronaca nera del quotidiano cagliaritano: l’avevano preso mentre tentava di carezzare le cosce e il cazzo di un biondino, in un cinema del centro. Il biondino aveva urlato: le luci si erano accese in un attimo, e i numerosi spettatori di “Lucy a gambe aperte” avevano visto le maschere che fermavano – leggermente impaurite, invero – quell’omaccione dall’aspetto tutt’altro che equivoco, che si è lasciato condurre pacificamente in questura, senza fare male a nessuno, mentre un biondino magrolino gli urlava dietro “finocchio di merda.” E fra i due proprio lui sembrava il finocchio, e l’altro l’avresti detto un maschio con quattro palle, a vedere quel naso sfatto, quegli occhi sfigurati, quelle braccia da giovane ercole.
In questura il commissario Brigaglia – vecchio patito della boxe, che sa tutto su tutti coloro che hanno poggiato i piedi sui ring isolani – l’ha riconosciuto subito. “Casu” gli ha detto “o è uno scherzo o sei diventato tutto matto” e Marcello gli ha letto negli occhi che sarebbe bastata una parola, una sola, magari anche soltanto un sorriso, e in guardina sarebbe finito il biondino, che l’aria da finocchietto non gliela toglieva proprio nessuno.
Ma Marcello, onesto e limpido, “Caro commissario” gli ha detto “a me, le donne, non piacciono. E a lei?”