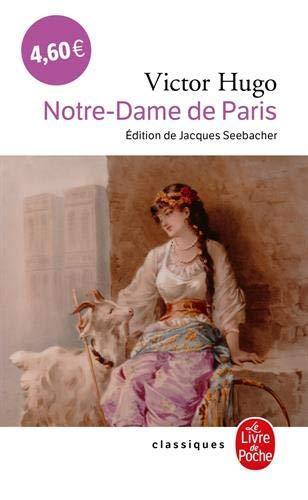cretinodicrescenzago ha recensito Notre-Dame de Paris di Victor Hugo
Incomprensibile se letto a scatola chiusa, pregevole se contestualizzato come romanzo antico
3 stelle
Una premessa doverosa. Per principio io recensisco solo testi composti da inizio Novecento in poi, perché trovo fuori luogo valutare in questa sede opere più antiche; le letterature europee da Omero al XVIII secolo avevano alle spalle ecosistemi editoriali e canoni estetici profondamente diversi dai nostri e per fruirle come si deve è pressoché obbligatorio ricostruire quei contesti di composizione attraverso studi storici preliminari, ma ciò rende la lettura delle "antichità" qualitativamente diversa (e quindi non paragonabile) a quella di un testo contemporaneo. Questo mio principio personale, prevedibilmente, salta in aria con le opere dell'Ottocento, cioè quelle che hanno fatto da trait d'union fra le Belle Lettere elitarie e la letteratura di massa contemporanea: non so mai se fruirle come "antichità" che richiedono una preparazione a monte o come testi "autosufficienti" che si possano approcciare a scatola chiusa, come se fossero usciti ieri. Io per prudenza propendo sempre per la …
Una premessa doverosa. Per principio io recensisco solo testi composti da inizio Novecento in poi, perché trovo fuori luogo valutare in questa sede opere più antiche; le letterature europee da Omero al XVIII secolo avevano alle spalle ecosistemi editoriali e canoni estetici profondamente diversi dai nostri e per fruirle come si deve è pressoché obbligatorio ricostruire quei contesti di composizione attraverso studi storici preliminari, ma ciò rende la lettura delle "antichità" qualitativamente diversa (e quindi non paragonabile) a quella di un testo contemporaneo. Questo mio principio personale, prevedibilmente, salta in aria con le opere dell'Ottocento, cioè quelle che hanno fatto da trait d'union fra le Belle Lettere elitarie e la letteratura di massa contemporanea: non so mai se fruirle come "antichità" che richiedono una preparazione a monte o come testi "autosufficienti" che si possano approcciare a scatola chiusa, come se fossero usciti ieri. Io per prudenza propendo sempre per la prima opzione, ma la cultura scolastica media tende a imporci la seconda (se no non esisterebbe il concetto di "Classico senza tempoTM"), quindi ho deciso di mettermi alla prova: da persona cui è piaciuto leggere I Promessi Sposi alla scuola dell'obbligo, mi sono tuffato senza contestualizzazione preliminare in Notre-Dame de Paris, il "primo grande capolavoro del romanticismo francese e modello di quello italiano", per scoprire se davvero è "un'opera senza tempo che ci parla ancora dopo due secoli".
Esito dell'esperimento: negativo. Non nascondiamoci dietro a un dito, per i nostri canoni il romanzo è tremendamente datato, un archetipo divenuto ormai stereotipo che si apprezza essenzialmente come "antichità" da contestualizzare con studi preliminari.
Iniziamo con tutti quegli aspetti che, letti oggi a secco, ci sanno di visto e stravisto e ampiamente superato dalle generazioni successive: la voce narrante di Hugo è saccente e petulante come sa esserlo solo quella di un giovane strafottente che compone un romanzo a tesi; gli inserti saggistici sull'urbanistica di Parigi e le sue istituzioni giuridiche uccidono il ritmo da far spavento (quelli sull'alchimia invece sono pregevoli!); i riferimenti eruditi alla corte e ai cortigiani di re Luigi XI potevano essere gustosissimi per il pubblico originale di riferimento, ma ora sono oscuri e leziosi e richiederebbero pagine e pagine di apparato critico (che la mia edizione non propone, ma da una brossura economica è ingiusto pretenderle); la sezione introduttiva del romanzo è visualizzata dalla prospettiva di Pierre Grignoire, un odioso pallone gonfiato e (temo) un avatar autoriale di Hugo, che grazie al cielo diventa più avanti un'efficiente spalla comica; quasi metà del romanzo è dedicata a presentare gli antefatti e gli incidenti scatenanti della vicenda, che sono perpetuamente dilatati dalle digressioni di cui sopra; il nucleo principale dell'azione è appesantito da monologhi interiori dei personaggi, alcuni dei quali (per lo più di Esmeralda) mi fanno sospettare che Hugo avesse dei seri problemi a empatizzare con gli altri e a esternare le emozioni in modo funzionale (ma forse sono solo io che ho in profondo odio il petrarchismo e tutte le sue emanazioni); il grosso degli eventi accade nella fase finale del romanzo e, a quel punto, indubbiamente ti incolla alla pagina – ma ci riesce perché tutta la macchina narrativa si basa su coincidenze fortuite scappate da una tragedia pseudogreca media. Hugo è stato indubbiamente onesto (o furbastro, se siamo in malafede) a esplicitare che il tema portante della vicenda è la "Fatalità" o "Necessità cosmica" o "Anànke" che prevale sull'arbitrio umano, ma imbastire un'intera opera su tale tema (o stereotipo) era già da letterato paludato nei suoi tempi – persino un conservatore compunto quale Manzoni ebbe la decenza, quando emulò di Hugo una decina di anni dopo, di basare il suo romanzo sull'interazione fra libero arbitrio umano e Provvidenza divina.
Al netto di questa tirata, non intendo dire che Notre-Dame de Paris sia una fetenzia che ha avuto successo, a suo tempo, solo perché spiccava vagamente entro un'offerta artistica disastrata. Al contrario, se depongo la speranza di godermelo a scatola chiusa e lo inquadro in quel poco che so sulla storia letteraria francese, risulta un'"antichità" supremamente interessante: è indiscutibile che Hugo abbia dato il La a praticamente tutti i canoni della narrativa romantica. Medievalismo; moralismo; intrecci convoluti; inserti saggistici di storia politica e dell'arte; trame corali che uniscono figure di Grande Storia, personaggi fittizi e masse popolari; situazioni macabre e scollacciate recuperate dal Gotico inglese; uno sguardo esotizzante verso la plebe che non diventa mai istanza egalitaria sincera – c'è praticamente tutto e temo si possa ben dire che chi legge Notre-Dame de Paris ha già letto tutti i romanzi romantici di tutte le lingue. Dubito che qualcuno sia riuscito a superare Hugo e a comporre un "romanzo mondo" ancora più onnicomprensivo (ma se avete dei candidati, proponetemeli!), e riesco solo vagamente a immaginare quanto una struttura del genere fosse rivoluzionaria nel 1831 (per immaginarlo bene mi servirebbe una preparazione a monte più dettagliata). In più, ho come il sospetto che Hugo sia uno di quei prosatori poco abili a strutturare con efficacia l'intreccio ma "belli da stare a sentire" grazie a una voce narrante sofisticata e a sapienti espedienti lessicali, ma se così è la mia traduzione non riesce più di tanto a trasporre in Italiano il suo talento retorico – ammesso che sia possibile riuscirci. Purtroppo non ho le competenze per leggerlo in Francese, ma magari un domani...
Tirando le fila del mio discorso, consiglio a tutti di leggere Notre-Dame de Paris, ma non azzardatevi a prenderlo in mano a scatola chiusa: vi trovereste davanti un rudere sbricolatosi con i secoli. Procuratevi invece un'edizione con un ampio apparato e una storia della letteratura francese e iniziate il romanzo solo dopo aver ricostruito il contesto della pubblicazione originaria: vi troverete davanti uno snodo fondamentale delle lettere europee.
In chiusura, evito di dare un voto al buon Hugo, per aderire almeno in parte al mio fioretto di valutarlo con altri metri; se proprio ci tenete a saperlo, sarebbe un 2,5/5 – perché non c'è un personaggio principale che non sia in qualche modo odioso, tranne il povero Quasimodo e la capra Djali (sogghigno malvagio).